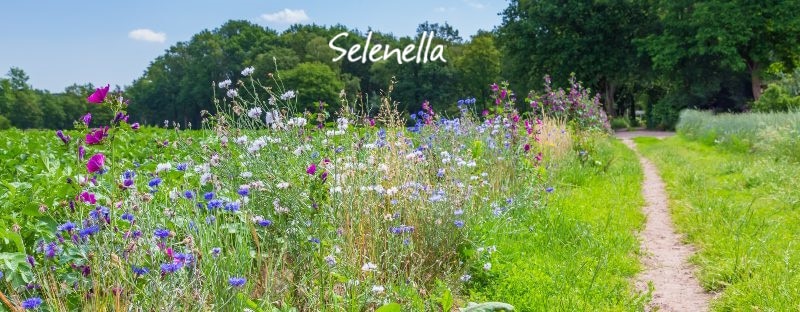
INTREEGUE Photography/Shutterstock
Biodiversità e patate: il valore nel nostro piatto
La biodiversità è un elemento fondamentale del nostro sistema alimentare, una risorsa strategica per la resilienza agricola e un pilastro della sicurezza alimentare globale
Biodiversità: cos’è e perché è importante
Il termine “biodiversità”, abbreviazione di “diversità biologica”, è un termine utilizzato per indicare la varietà di organismi viventi presenti sul Pianeta a tutti i livelli della loro organizzazione: genetica, di specie e di ecosistemi. Questa definizione, sancita ufficialmente dalla Convenzione sulla Diversità Biologica delle Nazioni Unite nel 1992, è il frutto di una lunga evoluzione scientifica e culturale, che ha portato a riconoscere la biodiversità come un elemento imprescindibile per garantire stabilità ecologica, benessere umano e sviluppo sostenibile.
La biodiversità fornisce un insieme di servizi ecosistemici, cioè benefici offerti dagli ecosistemi naturali e agricoli. Esempi di servizi ecosistemici sono la purificazione dell’aria e delle acque, la regolazione del clima, la fertilità del suolo, la protezione contro le inondazioni e il controllo naturale di parassiti e patogeni. Di conseguenza, senza biodiversità, gli ecosistemi sarebbero incapaci di rigenerarsi e di sostenere la vita, inclusa quella umana.
In ambito agricolo la variabilità tra specie e all’interno delle specie coltivate e allevate permette di affrontare le conseguenze del cambiamento climatico. Questo perché una coltura geneticamente diversificata risulta più adattabile, più resiliente agli stress ambientali e richiede meno interventi contro parassiti e malattie. Avere a disposizione una diversità genetica in agricoltura permette quindi di selezionare varietà resistenti alla siccità, alle alte temperature, a suoli poveri o ad agenti patogeni, aumentando così la sicurezza alimentare. Perdere biodiversità si traduce in una riduzione della capacità di adattamento dei sistemi agroalimentari, li rende più vulnerabili a shock ambientali, fitosanitari o economici, e aumenta il rischio di crisi sistemiche.
Oltre alla varietà genetica esiste anche una biodiversità culturale legata a pratiche agricole tradizionali, a varietà locali e alle conoscenze accumulate nel tempo dalle comunità contadine. Queste varietà, selezionate nei secoli per adattarsi ai microclimi e ai terreni locali, rappresentano un patrimonio non solo biologico, ma anche storico, sociale e identitario. La loro erosione può essere causata dall’omologazione imposta dall’agricoltura industriale e comporta la perdita di saperi, gusti, resilienza territoriale.
Tutelare la biodiversità risulta quindi una scelta urgente e per proteggere la nostra alimentazione, costruire un’agricoltura più equa e sostenibile e rafforzare la nostra capacità collettiva di affrontare il futuro ed è una responsabilità che riguarda chi produce, ma anche chi distribuisce, regola e consuma.

Olga Miltsova/Shutterstock
Biodiversità e agricoltura: un equilibrio da proteggere
L’agricoltura rappresenta un settore produttivo in cui vi è un’interazione continua tra ambiente, uomo e risorse naturali, in cui la biodiversità gioca un ruolo fondamentale. Senza varietà biologica, infatti, l’agricoltura diventa vulnerabile, rigida, esposta al fallimento. Il modello agricolo intensivo ha dominato il settore negli ultimi decenni provocando una drastica riduzione della biodiversità.
La selezione di poche varietà ad alta produttività, spesso ibride o geneticamente uniformi, ha portato a una semplificazione estrema dei paesaggi agricoli. Interi territori sono oggi occupati da colture geneticamente identiche, coltivate su larga scala e con l’ausilio fertilizzanti. Questo approccio ha garantito alte rese nel breve termine, ma nel lungo periodo ha determinato un impoverimento del suolo e reso le colture più vulnerabili a patogeni e parassiti, riducendo così la capacità dell’agroecosistema di rigenerarsi.
Per questo, negli ultimi anni si sta assistendo a un’inversione di tendenza: si è iniziato a parlare di agricoltura sostenibile e, in questo contesto, è cresciuto l’interesse per la tutela delle varietà locali, il recupero dei semi antichi, l’agricoltura biologica e rigenerativa e si sono diffuse banche di semi per conservare la diversità genetica a rischio di estinzione.
La biodiversità agricola comprende sia le specie coltivate che quelle spontanee presenti nei campi, nei margini, nei prati e nei boschi vicini, ma anche gli animali domestici, i microrganismi del suolo e le specie impollinatrici. Si tratta di una rete complessa che permette al sistema agricolo di funzionare poiché include la scelta di coltivare varietà diverse per creare un sistema più stabile, ma anche quelle di tutelare gli impollinatori e i microorganismi che vivono nel suolo, per aumentare le rese agricole e mantenere il suolo fertile.
Per proteggere la biodiversità in agricoltura è quindi necessario che avvenga una transizione da un modello produttivo fondato sull’omogeneità e la quantità a uno fondato sulla diversità, la qualità e la cura del territorio. È una sfida, ma anche una grande opportunità per ricostruire un’agricoltura più sana, equa e in armonia con la natura.

Hryshchyshen Serhii/Shutterstock
Biodiversità nel settore delle patate
La patata è una delle colture alimentari più diffuse al mondo: originaria delle Ande sudamericane, questa pianta appartenente alla famiglia delle Solanacee vanta una biodiversità straordinaria, oggi in parte dimenticata. Esistono infatti oltre 4.000 varietà tradizionali coltivate localmente in Sud America, ma solo una minima parte è arrivata fino ai mercati europei, dove dominano poche varietà commerciali selezionate per uniformità estetica, produttività e resistenza al trasporto.
Anche in Italia, dove la coltivazione della patata ha una lunga tradizione, la biodiversità del comparto pataticolo è minacciata da un modello agricolo orientato alla standardizzazione. Molte varietà locali sono andate perdute o sopravvivono in aree ristrette, coltivate da piccoli produttori e comunità montane. Basti pensare alla patata turchesa abruzzese, alla patata quarantina ligure, o alla patata del Fucino: tutte testimonianze di un’agrobiodiversità ricca, legata ai territori e spesso ancora poco valorizzata.
In un contesto dove l’omologazione minaccia la sicurezza alimentare e la resilienza delle colture, la diversificazione varietale delle patate diventa una strategia vincente. Avere a disposizione varietà di patate adatte a suoli sabbiosi, altre più resistente alle malattie, altre ancora con proprietà nutrizionali specifiche significa avere risorse preziose che possono garantire un’agricoltura più flessibile, meno dipendente dai fitofarmaci e più sostenibile.
Negli ultimi anni stiamo assistendo a un significativo recupero del valore della biodiversità pataticola, anche grazie al lavoro di consorzi, aziende e progetti territoriali che puntano sulla qualità e sulla sostenibilità. Un esempio è il Consorzio Patata Italiana di Qualità, che commercializza il marchio Selenella. Questa realtà rappresenta un modello virtuoso di filiera corta e controllata, che coniuga innovazione, sostenibilità e attenzione alla diversità genetica. I controlli sono rigorosi lungo tutta la filiera, dalla produzione al confezionamento, con una forte attenzione alla qualità organolettica e nutrizionale.
Selenella promuove una pataticoltura che si fonda su pratiche agronomiche a basso impatto ambientale e che tutela la biodiversità nel settore pataticolo. Nella selezione delle varietà di patate, ad esempio, il Consorzio investe in miglioramento varietale grazie alla collaborazione con centri di ricerca e istituzioni agrarie, contribuendo così alla tutela della biodiversità nel settore.
Il caso di Selenella dimostra che è possibile conciliare esigenze di mercato, innovazione tecnologica e salvaguardia del patrimonio agricolo investendo nel futuro del sistema agroalimentare con ripercussioni positive anche sul territorio, sulla salute e sul lavoro dei produttori.


